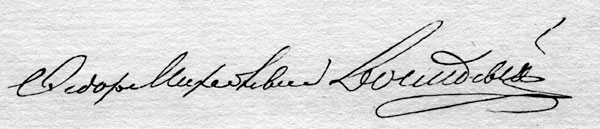V • Gli starcy
REALISMO E FEDE
... ma a me sembra che Alëša fosse persino più realista di molti
altri.
Certo, quando era al monastero egli credeva fermamente nei miracoli
ma, secondo me, i miracoli non metteranno mai a disagio un realista. Non
sono i miracoli a fare propendere il realista verso la fede. Un vero realista,
se non è credente, troverà sempre in se stesso la forza e la capacità di non
credere neanche nel miracolo, ma se il miracolo diventasse un fatto
innegabile lì davanti ai suoi occhi, egli sarebbe disposto a non credere ai
propri sensi piuttosto che ammettere il fatto. E se lo ammettesse, lo
ammetterebbe come un fatto naturale fino a quel momento a lui ignoto. In
un realista non è la fede a nascere dal miracolo, ma è il miracolo a nascere
dalla fede. E una volta che il realista crede, allora egli dovrà
inevitabilmente ammettere, proprio per via del suo realismo, anche il
miracolo. L'apostolo Tommaso disse che non avrebbe creduto finché non
avesse visto e quando vide disse: «Signore mio, Dio mio!» Fu il miracolo a
costringerlo a credere? È molto probabile di no: egli credette unicamente
perché voleva credere e, forse, già credeva ciecamente, nel profondo del
suo cuore, persino quando diceva: «Non crederò finché non avrò veduto».
Mi si potrà dire che Alëša fosse ottuso, poco colto, che non aveva
finito la scuola e così via. Che non avesse finito la scuola è vero, ma dire
che egli fosse ottuso o stupido sarebbe una grave ingiustizia. Ripeterò
semplicemente quello che ho già detto: egli imboccò quella strada
unicamente perché, a quel tempo, essa sola lo aveva colpito e si presentava
a lui, per così dire, come l'ideale dell'esodo della sua anima che si
strappava dalle tenebre per andare verso la luce. Aggiungete a questo che
egli era già, in parte, un giovane dei nostri tempi, cioè onesto di natura,
uno che desiderava la verità, la ricercava e ci credeva, e quando credeva in
qualcosa, voleva prendervi parte immediatamente, con tutta la forza della propria anima, e poi sentiva l'esigenza dell'azione immediata e
l'irresistibile desiderio di sacrificare anche tutto per essa, persino la vita.
Eppure, purtroppo, questi giovani non si rendono conto che il sacrificio
della vita è, forse, in molti casi, il più facile fra tutti i sacrifici e che
sacrificare, per esempio, cinque o sei anni della propria impetuosa
giovinezza a uno studio arduo e faticoso, al sapere, sebbene allo scopo di
decuplicare in se stessi le forze per servire quella stessa verità e quella
stessa causa che si è presa a cuore e che ci si è proposti di perseguire, è
molto spesso superiore alle forze di molti di loro. Alëša aveva scelto la
strada opposta a quella di tutti gli altri, ma con la stessa brama di azione
immediata. Non appena si fu convinto, dopo una seria riflessione,
dell'esistenza di Dio e dell'immortalità, egli si era subito detto,
istintivamente: «Voglio vivere per l'immortalità, non accetto
compromessi». Allo stesso modo, se avesse concluso che l'immortalità e
Dio non esistono, sarebbe passato, detto fatto, dalla parte degli atei e dei
socialisti (giacché il socialismo non è solo la questione operaia, o il
cosiddetto quarto stato, ma è principalmente la questione dell'ateismo, la
questione della forma che l'ateismo assume oggi, la questione della torre di
Babele costruita senza Dio, non già per raggiungere il cielo dalla terra, ma
per portare il cielo sulla terra). Ad Alëša sembrava persino strano e
impossibile continuare a vivere come prima. È scritto: «Da' tutto quello
che hai e seguimi se vuoi essere perfetto». E anche Alëša aveva detto a se
stesso: «Non posso dare due rubli al posto di "tutto" e andare alla messa
invece di "seguire Lui"». Forse nei ricordi della sua prima infanzia era
rimasta traccia del monastero alla periferia della nostra cittadina, dove la
madre probabilmente lo portava a messa. Può darsi che sulla sua
immaginazione abbiano influito anche i raggi obliqui del sole che
tramontava davanti all'immagine sacra, verso la quale lo protendeva la sua
mamma, la klikuša. Tutto assorto nei suoi pensieri era arrivato da noi,
forse solo per dare un'occhiata, per vedere se lì si dava tutto o soltanto due
rubli, ma poi nel monastero aveva incontrato quello starec...
LO STAREC ZOSIMA
Quello starec, come ho già spiegato prima, era lo starec Zosima; ma
a questo punto bisognerebbe spiegare chi siano in generale gli starcy nei
nostri monasteri ed è un peccato che in questo campo non mi senta
abbastanza competente e ferrato. Tenterò comunque di dire quattro parole
a proposito, a grandi linee. In primo luogo, i competenti e gli specialisti
dicono che gli starcy e l'istituto dello starèestvo abbiano fatto la loro
comparsa fra di noi, nei nostri monasteri russi, in tempi molto recenti - pare che non sia passato nemmeno un secolo - mentre in tutto l'Oriente
ortodosso, in particolare nel Sinai e sul Monte Athos, esistono da più di
mille anni. Sostengono che lo starèestvo sia esistito anche da noi nella Rus'
in tempi remoti, o per lo meno che debba senz'altro essere esistito, ma in
seguito alle sciagure che si abbatterono sulla Russia - il dominio tataro, il
periodo dei torbidi, l'interruzione delle precedenti relazioni con l'Oriente,
seguita alla conquista di Costantinopoli, - questa istituzione cadde
nell'oblio e gli starcy cessarono di esistere. Lo starèestvo venne ripristinato
fra noi verso la fine del secolo scorso, per merito di uno dei grandi
anacoreti (come lo chiamano), Paisij Velièkovskij, e dei suoi discepoli, ma
a tutt'oggi, dopo ben cento anni, questo istituto esiste solo in pochi
monasteri ed è stato persino oggetto di una sorta di persecuzione, come
fosse stata un'innovazione inaudita in Russia. Lo starèestvo ha prosperato
nella nostra Rus' soprattutto nel celebre eremitaggio di Kozel'skaja Optina.
Ignoro chi e quando lo abbia introdotto nel monastero alla periferia della
nostra città, ma a quel tempo vi si contava già la terza generazione di
starcy, l'ultima delle quali era rappresentata dallo starec Zosima, ma anche
lui ormai stava morendo per il deperimento e la malattia e non vi era
nessuno che potesse prendere il suo posto. Era una questione importante
per il nostro monastero, poiché fino ad allora esso non si era distinto per
nulla di particolare: non vi si conservavano reliquie di santi, né icone
miracolose, non godeva nemmeno di tradizioni gloriose legate alla nostra
storia, non figuravano a suo nome imprese storiche o meriti patriottici.
Aveva prosperato ed acquisito fama in tutta la Russia proprio grazie agli
starcy; per vederli e ascoltarli affluivano da noi moltitudini di fedeli
dall'intera Russia, anche da migliaia di verste di distanza. Ma allora che
cos'è uno starec? Lo starec è colui che accoglie la vostra anima, la vostra
volontà nella propria anima, nella propria volontà. Quando scegliete uno
starec, voi rinunciate alla vostra volontà e gliela affidate in completa
sottomissione, con assoluta abnegazione. Questo tirocinio, questa terribile
scuola di vita viene accettata spontaneamente da colui che offre se stesso,
nella speranza, al termine della lunga prova, di sconfiggere il proprio
essere e di dominarsi fino al punto di conquistare infine, attraverso una
vita di ubbidienza, la libertà assoluta, vale a dire la libertà da se stesso, per
evitare il destino di coloro che hanno vissuto tutta una vita senza trovare
dentro di sé se stessi.

Questa istituzione, lo starèestvo appunto, non è
fondata sulla teoria, ma è nata in Oriente da una pratica ormai millenaria.
Gli obblighi nei confronti dello starec non corrispondono alla consueta "ubbidienza" che è sempre esistita nei nostri monasteri russi. Lo starèestvo
impone la confessione perpetua di tutti coloro che si sono assoggettati allo
starec e il legame indissolubile tra colui che lega e colui che è legato. Si
narra per esempio che una volta, agli albori del cristianesimo, un novizio
che non aveva eseguito un certo ordine impartitogli dallo starec, lasciò il
suo monastero in Siria e andò in Egitto. Lì, dopo molte grandi imprese,
meritò finalmente di patire i tormenti e il martirio per la fede. Mentre la
comunità, che lo considerava già un santo, gli dava una degna sepoltura,
all'esclamazione del diacono: «Catecumeni, uscite», la bara con il corpo
del martire si staccò dal suo posto e fu scaraventata fuori dalla chiesa per
ben tre volte. Solo alla fine vennero a sapere che quel santo martire aveva
rotto il voto di ubbidienza abbandonando il suo starec e per questo, senza
l'assoluzione dello starec, non poteva nemmeno essere perdonato
nonostante avesse compiuto grandi gesta. Solo quando lo starec,
convocato per l'occasione, lo sciolse dal voto di ubbidienza, poté aver
luogo la sepoltura. Naturalmente, questa è solo un'antica leggenda, ma
ecco un episodio recente: un monaco dei giorni nostri conduceva vita
ascetica sul Monte Athos quando un bel giorno il suo starec gli ordinò di
lasciare il Monte Athos, che egli amava con tutta la sua anima come una
cosa sacra, come un rifugio di pace, e di andare prima a Gerusalemme a
rendere omaggio ai luoghi sacri, e poi di tornare in Russia, al nord, in
Siberia: «Là è il tuo posto, non qui». Confuso e stravolto dal dolore, il
monaco si presentò dal patriarca ecumenico a Costantinopoli e lo pregò di
scioglierlo dal voto di ubbidienza; ma ecco che l'autorità suprema gli
rispose che non solo lui, patriarca ecumenico, non poteva fare una cosa
simile, ma che in tutta la terra non c'era, né ci poteva essere autorità in
grado di scioglierlo dal voto d'ubbidienza, una volta che questo gli era
stato imposto da uno starec, fatta eccezione per l'autorità di quello stesso
starec che glielo aveva imposto.
Quindi gli starcy sono investiti di un
potere che in certi casi è assoluto e imperscrutabile. Ecco perché in molti
monasteri da noi lo starèestvo è stato persino oggetto di persecuzione. Nel
contempo il popolo ha cominciato immediatamente a nutrire un grande
rispetto per gli starcy.
Dagli starcy del nostro monastero, per esempio,
affluivano in massa sia gente del popolo sia persone eminenti allo scopo di
prostrarsi dinanzi a loro e confessare i propri dubbi, i propri peccati, le
proprie sofferenze, chiedere consiglio e guida. Vedendo questo, i detrattori
degli starcy gridavano, oltre alle solite accuse, che qui si mortificava con
arroganza e leggerezza il sacramento della confessione, sebbene la pratica di aprire continuamente la propria anima allo starec da parte del novizio e
dei laici non abbia affatto il carattere di sacramento. Comunque, l'istituto
dello starèestvo ha finito col resistere a queste accuse e pian pianino sta
prendendo piede nei monasteri russi. Forse è anche vero che questo
sperimentato e ormai millenario strumento di rigenerazione morale
dell'uomo dalla schiavitù alla libertà e al perfezionamento morale può
trasformarsi in un'arma a doppio taglio, perché potrebbe condurre
qualcuno, invece che all'umiltà e al completo autocontrollo, proprio
all'orgoglio più satanico, e quindi alla schiavitù e non alla libertà.

Lo starec Zosima aveva circa sessantacinque anni, proveniva da una
famiglia di proprietari terrieri; un tempo, nella prima giovinezza, era stato
militare e aveva prestato servizio in Caucaso con il grado di ufficiale
superiore. Senza dubbio, egli aveva colpito Alëša per qualche speciale
qualità della sua anima. Alëša viveva nella stessa cella dello starec, che lo
amava molto e lo aveva accolto presso di sé. Occorre notare che, pur
vivendo nel monastero, Alëša allora non aveva alcun obbligo, poteva
andare dove voleva, assentarsi anche per giorni interi, e se indossava la
tonaca, lo faceva volontariamente, per non distinguersi dagli altri. E senza
dubbio questo gli faceva piacere. È probabile che sull'immaginazione
giovanile di Alëša producesse un forte effetto il potere e la fama che
circondavano incessantemente la persona dello starec. Dello starec
Zosima molti dicevano che, avendo egli ammesso alla propria presenza,
per tanti anni, tutti quelli che venivano ad aprirgli il proprio cuore,
desiderosi di un suo consiglio e di una sua parola consolatoria, aveva
accolto nella sua anima tante di quelle rivelazioni, sofferenze, confessioni
da acquisire alla fine una preveggenza così acuta che gli bastava
un'occhiata al viso dello sconosciuto visitatore per intuire il motivo della
sua visita, che cosa voleva e persino che tipo di sofferenza tormentava la
sua coscienza; egli alle volte destava meraviglia, turbamento e persino
spavento nel suo visitatore quando questi si accorgeva che lo starec
conosceva il suo segreto prima ancora di aver aperto bocca. Ma Alëša
notava quasi sempre che molti, quasi tutti, coloro che si recavano per la
prima volta dallo starec per un colloquio a quattr'occhi, entravano
impauriti e agitati ma uscivano sereni e contenti, e anche il viso più cupo
diveniva felice. Alëša fu particolarmente impressionato anche dal fatto che
lo starec non era affatto severo; al contrario egli era quasi sempre allegro.
I
monaci dicevano che egli si affezionava a chi aveva più peccato: più uno
aveva peccato e più egli lo amava. Fra i monaci ci furono quelli che odiarono e invidiarono lo starec fino alla fine dei suoi giorni, ma erano
rimasti in pochi e tacevano, sebbene tra di loro ci fossero alcune
personalità molto note e importanti nel monastero, come per esempio uno
dei monaci più anziani, un campione nell'attenersi alla regola del silenzio e
uno straordinario digiunatore.
Tuttavia la stragrande maggioranza stava
ormai, senza ombra di dubbio, dalla parte dello starec Zosima e fra di essi
molti lo amavano con tutto il cuore, fervidamente, sinceramente; alcuni
nutrivano per lui una devozione che sfiorava il fanatismo. Questi ultimi
dichiaravano apertamente, ma non proprio ad alta voce, che egli era un
santo, che non c'erano più dubbi su questo, e, prevedendo l'imminente sua
dipartita, si attendevano addirittura miracoli immediati e una grande gloria
nel prossimo futuro per il monastero grazie all'estinto. Anche Alëša
credeva incondizionatamente nella potenza miracolosa dello starec, così
come incondizionatamente credeva al racconto della bara volata fuori dalla
chiesa.
Egli vedeva che molti dei fedeli che arrivavano con bambini o
anziani parenti malati affinché lo starec imponesse loro le mani e recitasse
una preghiera su di loro, tornavano ben presto, alcuni persino il giorno
dopo e, in ginocchio, in lacrime davanti allo starec, lo ringraziavano per la
guarigione dei loro malati. Si trattava di vera guarigione o soltanto di un
naturale miglioramento nel decorso della malattia? Alëša non si poneva
nemmeno una tale domanda, giacché egli era già fermamente convinto
della potenza spirituale del maestro e gioiva della gloria di lui come di un
trionfo personale. Il suo cuore palpitava in particolar modo, ed egli
sembrava tutto raggiante, quando lo starec usciva per incontrare la folla di
fedeli che aspettava la sua apparizione presso le porte dell'eremo: era tutta
gente semplice, convenuta da ogni parte della Russia apposta per vedere lo
starec e ricevere la sua benedizione. Essi si inchinavano dinanzi a lui,
piangevano, gli baciavano i piedi, baciavano la terra che lui calpestava,
urlavano, le donne protendevano verso di lui i propri figli, gli
avvicinavano le klikuši malate.
Lo starec parlava con loro, recitava una
breve preghiera, li benediceva e li congedava. Negli ultimi tempi si era
così indebolito per gli attacchi della malattia da non avere la forza di uscire
dalla cella, e i fedeli alle volte lo aspettavano nel monastero per alcuni
giorni. Alëša non si domandava nemmeno il motivo per cui lo amavano
tanto, si prostravano davanti a lui, piangevano per la commozione solo nel
vedere il suo viso. Egli comprendeva benissimo che per l'anima umile del
popolo russo, estenuato dalla fatica e dal dolore, e soprattutto dalle eterne
angherie e dal costante peccato, proprio e del resto dell'umanità, non ci poteva essere esigenza e consolazione più grandi di trovare un oggetto
sacro o un santo, cadere in ginocchio e prostrarsi davanti ad esso: «Da noi
c'è il peccato, l'ingiustizia, la tentazione, tuttavia esiste un posto sulla terra
dove c'è un santo, un essere superiore. In compenso da lui c'è giustizia, in
compenso egli conosce la verità; quindi esse non si estinguono sulla terra e
un giorno verranno anche da noi e regneranno su tutta la terra, come ci è
stato promesso». Alëša sapeva che il popolo pensa e ragiona proprio in
questo modo, egli questo lo comprendeva, e sul fatto che lo starec fosse un
santo, il difensore della giustizia divina agli occhi del popolo - egli non
aveva il minimo dubbio al pari di quei contadini in lacrime e delle loro
donne malate che protendevano i figli verso lo starec. La convinzione che
lo starec, una volta morto, avrebbe portato al monastero una fama
straordinaria dominava l'anima di Alëša forse ancora più fermamente di
quella di chiunque altro al monastero. E in generale, in quell'ultimo
periodo, una sorta di profonda, ardente esaltazione interiore infiammava il
suo cuore con sempre maggior forza. Non era affatto turbato dal fatto che
quello starec fosse comunque un essere unico: «Egli è pur sempre un
santo, nel suo cuore è riposto il segreto della rigenerazione per tutti, quella
potenza che instaurerà finalmente la giustizia nel mondo e tutti saranno
santi, tutti si ameranno l'un l'altro, non ci saranno più ricchi e poveri,
trionfatori e umiliati, ma saranno tutti figli di Dio e avrà inizio il vero
regno di Cristo». Ecco quello che sognava Alëša nel suo cuore.
L'arrivo di entrambi i suoi fratelli, che fino a quel momento non
aveva mai conosciuto, sembrò produrre una fortissima impressione su
Alëša. Con il fratello Dmitrij Fëdoroviè, che pure arrivò più tardi, egli
instaurò subito un rapporto più intimo che con l'altro fratello (suo fratello
uterino), Ivan Fëdoroviè. Gli interessava moltissimo conoscere il fratello
Ivan, ma erano già due mesi che vivevano sotto lo stesso tetto, e sebbene si
vedessero abbastanza spesso, non avevano per niente familiarizzato: Alëša,
da parte sua, era taciturno e sembrava che aspettasse qualcosa, che fosse
intimorito da qualcosa, mentre Ivan, anche se Alëša aveva notato all'inizio
i suoi lunghi sguardi curiosi, ben presto non lo aveva più degnato di
attenzione. Alëša notò questo con un certo turbamento. Egli attribuì
l'indifferenza del fratello alla differenza d'età esistente fra di loro e
soprattutto al diverso grado di istruzione. Ma Alëša si domandava se
quell'assenza di curiosità e simpatia nei suoi confronti fossero causati da
qualcosa che egli ignorava del tutto. Gli sembrava, per qualche ragione,
che Ivan fosse assorbito da qualcosa, qualcosa di interiore e importante, che egli mirasse a uno scopo, forse, molto arduo da raggiungere, e che
quindi non avesse tempo per lui, e che quello fosse l'unico motivo per il
quale fosse così distratto nei suoi confronti. Alëša si domandava anche se
non si trattasse pure di disprezzo, il disprezzo di un colto ateo nei confronti
di uno stupido novizio. Egli sapeva benissimo che suo fratello era ateo.
Non poteva offendersi di quel disprezzo, se di disprezzo si trattava:
tuttavia, con un certo allarmato turbamento, a lui stesso incomprensibile,
aspettava il momento in cui il fratello avrebbe desiderato avvicinarsi a lui.
Il fratello Dmitrij Fëdoroviè mostrava una profondissima stima nei
confronti del fratello Ivan e parlava di lui con una certa gravità, tutta
speciale. Alëša aveva appreso da Dmitrij Fëdoroviè tutti i particolari di
quella importante faccenda che aveva legato i due fratelli negli ultimi
tempi in un rapporto stretto e straordinario. L'opinione entusiastica di
Dmitrij sul fratello Ivan era tanto più significativa agli occhi di Alëša in
quanto il fratello Dmitrij, in confronto a Ivan, era quasi del tutto privo di
istruzione ed entrambi, messi l'uno accanto all'altro, costituivano un tale
netto contrasto di personalità e carattere che, forse, sarebbe stato
impossibile concepire due persone più diverse di loro.
RIUNIONE DI FAMIGLIA
Fu proprio in quel periodo che ebbe luogo l'incontro o, per meglio
dire, la riunione fra tutti i membri di quella dissestata famiglia nella cella
dello starec, riunione che doveva avere una portentosa influenza su Alëša.
Il pretesto di quella riunione in realtà era inconsistente. In quel periodo il
disaccordo tra Dmitrij Fëdoroviè e Fëdor Pavloviè, in merito all'eredità e
alla valutazione dei beni, era arrivato a un livello intollerabile. I loro
rapporti si erano inaspriti ed erano diventati insostenibili.
IDEA DI FEDOR
Pare che Fëdor
Pavloviè avesse lanciato per primo, e per scherzo, l'idea che tutti si
riunissero nella cella dello starec Zosima, allo scopo, se non proprio di
ricorrere alla sua diretta intermediazione, almeno di giungere ad un
accordo in maniera più decorosa, sotto l'influenza ispiratrice e
riappacificatrice della dignità e della persona dello starec.
DMITRIJ ACCETTA LA PROPOSTA
Dmitrij
Fëdoroviè, che non aveva mai visitato né visto lo starec, pensò ovviamente
che il padre in quel modo lo volesse spaventare, ma poiché si era più volte
rimproverato in cuor suo di molti suoi recenti scatti d'ira nella disputa con
il padre, accettò l'invito.
Noteremo a proposito che egli non viveva in casa
del padre, come Ivan Fëdoroviè, ma per conto proprio, all'altro capo della
città.
MIUSOV ADERISCE
Accadde che anche Pëtr Aleksandroviè Miusov, che in quel periodo
viveva nella nostra città, si attaccasse in modo particolare a quella idea di
Fëdor Pavloviè. Liberale degli anni '40 e '50, libero pensatore e ateo, egli, forse per noia o forse per frivolo passatempo, ebbe un ruolo eccezionale in
quella vicenda.
Gli venne improvvisamente voglia di vedere il monastero e
il "santo".
Dal momento che ancora si protraevano le vecchie dispute con il
monastero ed andava per le lunghe la causa sul confine fondiario dei suoi
possedimenti, sui diritti di taglio nel bosco e di pesca nel fiume e via
dicendo, egli si affrettò a sfruttare la situazione con la scusa di volersi
mettere d'accordo di persona con il padre igumeno per vedere se fosse
possibile ricomporre i loro contrasti in maniera pacifica.
Avrebbero certo
accolto con maggiore attenzione e considerazione un visitatore animato da
tali lodevoli intenzioni, piuttosto che un semplice curioso. In seguito a
tutte queste considerazioni, si poté organizzare una specie di pressione
interna al monastero sullo starec malato che, negli ultimi tempi, non
abbandonava quasi mai la cella e, a causa della malattia, non riceveva
neanche i visitatori abituali.
LO STAREC FISSA LA DATA
Andò a finire che lo starec dette il suo
consenso e si fissò la data.
«Chi mi ha messo a fare da giudice fra di
loro?», si limitò a commentare con un sorriso ad Alëša.
Quando Alëša venne a sapere dell'incontro, ne fu molto turbato.
Egli capiva che, in mezzo a quei litiganti e contendenti, l'unico che
potesse prendere sul serio quel convegno era senza dubbio il fratello
Dmitrij; tutti gli altri sarebbero venuti con propositi fatui e forse anche
offensivi nei confronti dello starec.
Il fratello Ivan e Miusov sarebbero
venuti mossi dalla curiosità, e probabilmente della specie più volgare,
mentre suo padre sarebbe venuto forse allo scopo di recitare qualcuna delle
sue farse. Oh, anche se non parlava, Alëša conosceva a fondo suo padre!
Lo ripeto: quel ragazzo non era affatto così ingenuo come molti lo
consideravano. Attendeva con apprensione la data prefissata. Senza dubbio
egli si preoccupava molto, nel profondo del suo cuore, di come potessero
concludersi quei disaccordi familiari. Nondimeno era più di tutto
preoccupato per lo starec: egli trepidava per lui, per la sua fama, temeva
gli oltraggi alla sua persona, soprattutto l'ironia sottile e garbata di Miusov
e le mezze reticenze sprezzanti del colto Ivan: ecco come prevedeva che
sarebbe andata a finire.
Egli voleva quasi azzardarsi a mettere in guardia lo
starec, anticipargli qualcosa sulle persone che sarebbero potute venire, ma
ci ripensò e tacque.
MISSIVA A DMITRIJ
Mandò soltanto a dire al fratello Dmitrij, attraverso un
conoscente, alla vigilia dell'incontro che gli voleva molto bene, e che si
aspettava che lui mantenesse la promessa. Dmitrij stette lì a pensare,
perché non riusciva assolutamente a ricordare quale promessa gli avesse
fatto e rispose per lettera che avrebbe fatto del suo meglio per resistere «davanti alla bassezza», ma per quanto rispettasse profondamente lo starec
e il fratello Ivan, era convinto che quell'incontro sarebbe stato un tranello
per lui oppure un'indegna farsa.
«Tuttavia, ingoierei la lingua piuttosto che
mancare di rispetto a quel santo uomo che tu stimi tanto»: così concluse
Dmitrij la sua missiva. Alëša non ne fu gran che sollevato.